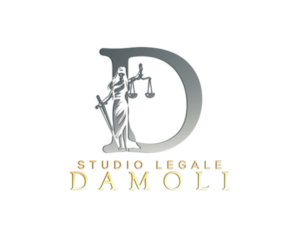La giurisprudenza prevalente ritiene che il contratto definitivo costituisca l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti, a differenza di parte della dottrina che, in virtù della teoria procedimentale, ritiene utile la valutazione del collegamento funzionale tra il preliminare ed il definitivo.
Il fatto
Il promissario acquirente di un immobile si è impegnato a versare, al compromesso, un terzo del prezzo pattuito per la compravendita e, al rogito, i restanti due terzi in contanti o mediante accollo di parte del mutuo residuo stipulato originariamente dal promissario venditore.
Nel contratto definitivo, tuttavia, le parti hanno pattuito che l’acquirente si accollava la parte di mutuo per l’intero sino all’estinzione.
Il venditore ha, allora, omesso il pagamento delle restanti rate del mutuo.
L’acquirente, chiesto del pagamento dalla Banca, ha citato in giudizio il venditore e il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che il contratto definitivo non potesse comportare a carico dell’acquirente l’assunzione di maggiori oneri non previsti né convenuti.
La Corte d’Appello, invece, qualificata la fattispecie come accollo cumulativo esterno, ha ritenuto che il pagamento rientrasse nell’obbligazione assunta, e quindi che l’accollo si estendesse a tutta la somma oggetto di mutuo.
L’acquirente ha, dunque, promosso ricorso per cassazione.
La pronuncia
Con l’ordinanza n. 21951, pubblicata il 2 settembre 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso perché fondato.
Nonostante sia pacifico che il contenuto dell’atto pubblico prevalga sul preliminare, quest’ultimo può in astratto essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti.
L’accollante ha dunque diritto di ripetere quanto pagato in più rispetto al prezzo pattuito per la compravendita.
Un’interpretazione diversa sarebbe contro il principio dell’interpretazione di buona fede, perché il compratore verrebbe a pagare un prezzo concordato e di gran lunga superiore.
Avv. Mattia Verza
Laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Verona, dopo aver conseguito l’abilitazione presso la Corte d’Appello di Venezia, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Verona. È esperto di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento al settore real estate.