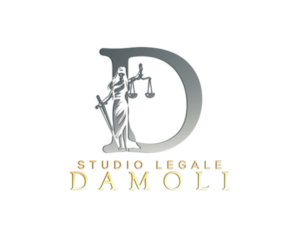Con la recente sentenza, pubblicata il 25 giugno scorso, la Corte di Cassazione ha riaffermato, nell’ambito della propria funzione nomofilattica, i requisiti che devono caratterizzare i criteri adottati dal Giudice del merito quando liquida il danno patrimoniale da lucro cessante, in particolare sotto il profilo del danno permanente da incapacità di guadagno.
Il fatto
Il signor P.D., giovane avvocato, a seguito di un sinistro stradale in cui il suo veicolo era stato investito dall’auto condotta da P.I., formulava richiesta di risarcimento dei danni all’impresa assicuratrice del veicolo antagonista la quale accordava il risarcimento, ammettendo l’esclusiva responsabilità del P.I. nella causazione dell’incidente.
Il P.D., il quale – si evince – aveva riportato lesioni permanenti invalidanti con importanti ripercussioni sulla propria vita privata e lavorativa, riteneva la somma liquidata dall’assicurazione non congrua e, pertanto, conveniva la compagnia avanti al Tribunale di Cremona chiedendo il risarcimento integrale dei danni subiti, quantificati in oltre due milioni di euro al netto della somma già ricevuta.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello di Brescia poi accoglievano parzialmente le istanze del P.D. in quanto, pur riconoscendo in entrambi i gradi di giudizio le basi per un’integrazione di quanto sino a quel momento ricevuto, riducevano sensibilmente le pretese risarcitorie in relazione al danno permanente da incapacità di guadagno.
Tale diversa quantificazione, sostiene il P.D., è errata in quanto da un lato si basa sull’applicazione dei coefficienti di capitalizzazione inseriti nelle tavole allegate al R.D. n. 1403/1922, ormai non più attuali, e dall’altro in quanto il calcolo risulta fatto tenendo conto di una base reddituale costante moltiplicata per gli anni residui di vita, mentre costituisce fatto noto che il reddito di un giovane professionista è destinato ad aumentare anno dopo anno.
Sulla base di questi motivi il P.D. ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La pronuncia
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l’errore di diritto lamentato dal ricorrente in relazione alla sentenza d’appello, la quale aveva disatteso un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, inaugurato nel 2015 e confermato anche nel 2019 con la sentenza n. 16913 in punto di quantificazione del danno permanente da incapacità di guadagno.
La Corte di Cassazione, infatti, illustra che, allo stato dell’arte, tale voce di danno “non può più liquidarsi utilizzando i coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D: n. 1403 del 1922 dal momento che questi (…) non sono più idonei a garantire un corretto risarcimento equitativo del danno e, pertanto, a rispettare il dettato dell’art. 1223 c.c.”.
Il Giudice del merito, infatti, pur nella sua autonoma scelta dei coefficienti di capitalizzazione che ritiene più idonei secondo il caso prospettato, deve tener conto di coefficienti supportati da basi scientifiche e attuali, come per esempio quelli utilizzati “per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali o i coefficienti elaborati in dottrina”.
Quanto alla base imponibile da utilizzare per il calcolo, la Corte pur non affrontando il motivo specifico in quanto ritenuto assorbito, riprende quanto affermato nella propria sentenza n. 10499 del 28 aprile 2017: dovrà tenersi conto della retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza “desunta da parametri di rilievo normativo o altrimenti stimata in via equitativa”.
document (1)
Avv. Alessandro Martini
Si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel novembre del 2011 con una tesi in diritto tributario sulla fiscalità dei nuovi strumenti finanziari partecipativi. Ad ottobre 2012 consegue un master di secondo livello presso l’Alta scuola di studi tributari A. Berliri di Bologna e si iscrive presso l’Ordine degli Avvocati di Trento nel 2017.